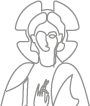30 marzo 2017
dal portale gionata.org
Intervento di Damiano Migliorini* all’incontro organizzato dal Gruppo di gay cristiani Emmanuele di Padova il 19 marzo 2017
“La misericordia non è una virtù naturale, che dipende dal carattere di ciascuno, ma è una disposizione interiore che matura e cresce stando insieme all’Amore”.
In questo breve intervento vorrei fornirvi, nella prima parte, delle coordinate esegetiche per il brano che mi è stato affidato (Luca 18,9-14). Nella seconda parte, invece, vi lascerò alcune riflessioni personali che vi prego di considerare dei semplici spunti. Né la parte esegetica, né la lettura “spirituale” successiva sono sistematiche. Sono riflessioni a voce alta, un tentativo di comprendere dei brani che, come vedremo, sono abbastanza destabilizzanti.
Leggiamo insieme buona parte del capitolo: 18, 1-27, e 35-43; come vedremo, è importante inserire il brano del fariseo e del pubblicano in un contesto più ampio.
PARTE PRIMA – Lettura e analisi dei testi
Due note di contesto: siamo nei capitoli 9-19, una parte che viene detta “la grande inserzione” di Luca. E’ una parte specifica di questo Vangelo: ciò che qui viene raccontato, non si trova negli altri Vangeli. Luca ha ritenuto importate riportare questi insegnamenti di Gesù, depositati nelle fonti orali delle comunità. A una lettura superficiale, i brani del cap. 18 sembrano accostati l’uno all’altro senza grande continuità; forse, tuttavia, una continuità, un’unità tematica c’è. Vedremo se riusciamo a scoprirla insieme. Del resto, i brani di un vangelo non sono – nella maggior parte dei casi – semplicemente messi in fila, ma sono raggruppati e organizzati secondo una loro certa affinità e con una logica, attorno a un nucleo teologico, il quale va scoperto, chiedendosi: perché il redattore ha posto i brani in quest’ordine? Perché questo brano proprio qui, assieme a questi altri brani?
Gesù è in viaggio verso Gerusalemme: la grande inserzione, dal punto di vista narrativo, è modulata intorno a questo viaggio. Un cammino pieno d’insegnamenti, che si susseguono, appunto, come delle pietre poste lungo il sentiero: un cammino che deve fare anche il discepolo nella maturazione della sua fede e della sua comprensione del Dio rivelato in Gesù, che gli apostoli avevano la fortuna di avere con loro, ma che spesso non riuscivano a comprendere. Ci mettiamo anche noi in cammino, consapevoli che c’è tanto nel nostro zaino che dobbiamo abbandonare: preconcetti e stereotipi sul nostro Dio che spesso ci impediscono di vivere un rapporto autentico con Lui. Pensiamo solo a quanto facciamo fatica a pensare al Dio misericordioso: il nostro istinto a porci come arbitri della sua giustizia è sempre dietro l’angolo… Va bene che Dio è buono, ma deve essere giusto, e lo deve essere così e così… Non pensiamo questo, in fondo? E non c’è molta idolatria in questa pretesa dell’uomo di circoscrivere la bontà di Dio?
Partiamo quindi dall’inizio. Ci avvicineremo progressivamente a quello che – a mio avviso – potrebbe essere l’idea teologica che Luca aveva in mente. Accumuleremo dati, indicazioni e stranezze dei brani (ci vorrà un po’ di pazienza, all’inizio!) che ci serviranno per abbozzare delle conclusioni. Il primo brano si apre con la dichiarazione dello scopo della parabola: spiegare perché è necessario pregare sempre, senza stancarsi mai. E’ difficile, qui, capire cosa possa voler dire quel “sempre” (ammesso che sia questa la traduzione migliore del greco!). Una persona non può certo pregare 24 ore al giorno! E’ possibile che Luca abbia un’idea simile a quella paolina della forma di “culto spirituale” (Rm 12,1)? In questo senso “pregare sempre” significa fare della propria vita un dono, durante la propria giornata. E’ probabile, comunque, che questo invito a pregare “sempre” sia legato al forte senso escatologico delle prime comunità cristiane, espresso nel v. 8: se il tempo è breve ci dedichiamo alle cose più importanti e spirituali; se invece il tempo si allunga, quel ‘sempre’ va forse re-interpretato e l’opzione “culto spirituale” sembra essere al più consona.
Sulla certezza dell’esaudimento si può leggere in parallelo anche 11, 9-13. Come mai Luca sente la necessità di sottolineare spesso tale certezza? E’ possibile che l’evangelista sfiori e percepisca che il tema della preghiera è scomodo: che le preghiere siano esaudite è probabile (e un cristiano difficilmente potrebbe negarlo), ma quando abbiamo pregato sufficientemente e sufficientemente bene, non è facile a dirsi. Qui si potrebbe aprire un discorso filosofico ampio sul senso stesso della preghiera[1] (possiamo chiedere qualcosa a un Dio che sa già tutto in anticipo?), ma non è di nostro interesse oggi. Cerchiamo piuttosto di entrare nelle pieghe dei brani e dei personaggi, in ordine. Strada facendo farò delle sottolineature “classiche”: quelle che qualsiasi sacerdote potrebbe fare dal pulpito, partendo da qualunque commentario. Solo in un secondo momento esprimerò quella che è la mia lettura.
La figura della vedova, nella prima parabola, viene spesso interpretata come personificazione di una sana cocciutaggine nel chiedere giustizia. La vedova, come sapete, nella cultura ebraica era un soggetto molto debole e vulnerabile, e questo rende ancor più straziante il rifiuto del giudice di farle giustizia. E’ però difficile pensare che Dio esaudisca le preghiere “per sfinimento”, come il brano lascia a intendere. Dobbiamo quindi interpretarne il senso. La cocciutaggine, si fa spesso notare, si riallaccia alla certezza del ritorno di Cristo e alla gravità del giudizio che egli darà a coloro che non operano secondo giustizia (v. 8). Poi viene introdotto un personaggio strano, una caricatura di un giudice e una caricatura di un uomo. Questa descrizione pittoresca è funzionale alla retorica del brano. Avrete infatti già notato la situazione curiosa che viene descritta: un giudice ingiusto che fa giustizia con un fine ingiusto (quello di togliersi la vedova dalle scatole). Certamente questo “far giustizia” va inteso in senso biblico: la giustizia di Dio è la giustizia che giustifica e salva, non quella che condanna. La situazione bizzarra serve al narratore per esprimere un concetto: se perfino un giudice ingiusto esaudisce le preghiere, non lo farà forse Dio?
Il narratore si rende conto, però, che l’argomentazione è debole. Sarà anche vero che il Dio sommamente buono agirà più degnamente del giudice ingiusto… Ma “sembra tardare parecchio”: Luca raccoglie l’obiezione classica che viene fatta, qualora si voglia sottolineare che non sempre Dio sembra esaudire le preghiere. Ecco allora che l’evangelista aggiunge un “prontamente”. Tuttavia, l’affermazione non risolve il problema: non è propriamente questa l’esperienza che facciamo! O almeno, sperimentiamo che tra il pregare e il suo effetto non c’è alcun automatismo. Che senso ha, allora, quel “prontamente”? A me sembra che il brano qui faccia un’affermazione che però va compresa a un livello più alto ancora, che vedremo solo alla fine. Teniamo comunque presente che Luca si rivolge a una comunità di perseguitati, alla quale è necessario dare una speranza e invitare a perseverare. Questo può darci qualche dritta, ma l’antinomia comunque resta.
Supponiamo però che Dio intervenga davvero subito per esaudire le preghiere. Il brano non si ferma qui, bensì riapre la questione, spostando ancora una volta il livello su una tematica diversa. E’ interessante l’avversativa: “Ma quando…”. Gesù sembra dire: se anche Dio facesse giustizia così (prontamente), questo basterebbe alla gente per credere? La domanda è retorica: per quanti gesti miracolosi Dio possa fare, la gente non crede comunque. “Troverà fede sulla terra?” Questa domanda è un po’ oscura: fa presagire che “l’esaudire le preghiere” sarà alla fine del mondo, ma l’esempio della vedova sembra escludere questa lettura. Quest’ultima domanda è comunque – questo ci dicono gli esegeti – un’aggiunta posteriore. Se è stata aggiunta qui, tuttavia, un motivo ci sarà. Perché il redattore ha inteso questa frase come ben coordinata alla parabola? Una risposta alla domanda del versetto si trova esplicitata in 17,26 (la piccola “apocalisse lucana”; a cui si somma la grande apocalisse di 21, 34-36): la maggior parte dei cristiani e degli uomini penserà solo alle cose terrene quando Cristo tornerà. Non ci sarà fede!
Lasciamo per ora aperta la questione. Tenendo a mente che la fede, qui, sembra legata al modello di Dio che abbiamo in mente. Potremmo sintetizzarla così: quando Gesù tornerà, ci saranno ancora persone che avranno fiducia nel Dio capace di ristabilire la giustizia, capaci quindi di pregare “sempre”? Uno spunto già ci è arrivato: giacché, quando Gesù tornerà, troverà tutti ‘nelle loro faccende affacendati’, ma non oranti, la conclusione che possiamo trarre è che “fede”, “stile di vita” e “preghiera” siano concetti interdipendenti: non si dà l’uno senza l’altro.
Passiamo allora alla seconda parabola. Curioso che essa sia rivolta “ad alcuni che si credevano giusti e disprezzavano gli altri”… E’ un “alcuni” retorico: difficile pensare che Gesù si stesse rivolgendo a qualcuno in particolare. Quel “alcuni” è un modo per dire “tutti”. Questo brano, almeno dall’incipit, sembra cambiare argomento, nonostante poi ci siano di nuovo due persone in preghiera. Il primo versetto tuttavia dà “il la” rispetto alla finalità del racconto parabolico, che non ha a che fare primariamente con la preghiera. Vediamo i personaggi. Il fatto che il primo sia un fariseo, già ci condiziona, perché siamo stati abituati fin da bambini a ritenere i farisei come figure negative; Luca stesso nei capitoli precedenti ha descritto i farisei usando parole molto dure. Sappiamo che è una generalizzazione ingenua, almeno rispetto alla cultura ebraica del tempo. Cerchiamo dunque di andare oltre le prime impressioni.
Di per sé la preghiera del fariseo parte bene: sta in piedi come d’usanza (anche il pubblicano sta in piedi[2]), ringrazia; ci sono anche elementi di positività: elenca le opere buone che ha fatto, anche più di quelle prescritte dalla Legge. Ma c’è qualcosa che intorbidisce la sua preghiera: a un certo punto, maledice! E la preghiera diventa autocondanna. Gli esegeti fanno notare che quest’uomo prega senza aspettarsi alcunché da Dio: è ben convinto che, compiendo le azioni previste dalla Legge, tutto gli sia dovuto. Il fariseo non chiede salvezza, perché è convinto di avercela già. Dio non c’è nella preghiera. O meglio, Dio c’è, ma in una versione idolatrica, falsa: proiezione del proprio ego e delle proprie convinzioni circa la salvezza, e dei modi attraverso cui tale salvezza si raggiunge. Dio è un distributore automatico di salvezza: faccio tre azioni, dico tre preghiere, mi spettano tre caramelle. Questa è una lettura piuttosto ingenua della “legge di retribuzione”, che era molto diffusa nella mentalità ebraica, tendente a pensare alla ‘ricompensa’ come qualcosa che l’uomo riceve nell’aldiqua. Siamo onesti: ci crediamo anche noi, ancora oggi! La frase “cosa ho fatto di male per meritarmi questo?” non è l’ammissione che crediamo ancora all’automatismo della legge di retribuzione? Che crediamo ancora in una misericordia meritata?
Il pubblicano invece non alza nemmeno lo sguardo al cielo (una nota: era questo il modo comune di pregare; forse Luca non conosceva bene le usanze ebraiche, oppure dobbiamo ammettere che tale frase è abbastanza oscura, o un’aggiunta inutile, o posteriore). Egli invoca misericordia, senza piegarla nei suoi schemi. Sembra intuire che, stando agli schemi, la misericordia non dovrebbe neppure invocarla. Altra nota interessante: il pubblicano non ha detto “scusami Signore, non lo farò più”. Ha solo detto di essere peccatore – e probabilmente crede pure che lo resterà a lungo. Eppure viene giustificato… Qui dovremmo entrare in questioni tecniche – viene giustificato e non santificato – ma andremmo piuttosto lontani.
Poi vi è un familiare “Vi dico”, una formula solenne nei Vangeli: Gesù esprime un giudizio chiaro. Il fariseo sarà abbandonato alla sua giustizia, mentre il pubblicano sarà giustificato. Il termine “giustificazione” è un segnale forte. Chiaramente qui c’è in gioco qualcosa di più della preghiera. E’ in campo l’intera idea cristiana di giustificazione. Un’idea di una scomodità tale che ci siamo fatti la guerra per secoli, senza venirne a capo. E finendo col formulare dei documenti di riconciliazione – parlo ovviamente della Dichiarazione congiunta tra cattolici e luterani – che attestano semplicemente l’impossibilità di fornire una dottrina razionale sulla giustificazione stessa. Il problema della giustificazione è che ci lascia sempre insoddisfatti, se vogliamo applicarci sopra le nostre ragioni. Nella parabola emerge con chiarezza che Dio non retribuisce in base ai nostri meriti. Lo vedremo tra poco.
Quella che qui vediamo all’opera, e che è all’opera anche nel brano del cieco, è la giustificazione “per fede”… “Fede” non è mai ben chiaro cosa sia: è la professione di fede? Fede operante? La fiducia? Nella dottrina cattolica, lo sapete, le “opere” non sono mai del tutto disgiunte dalla vera fede. Ciò che l’uomo fa è ciò che l’uomo è, e senza le opere – la chiesa insegna – la nostra fede è vuota, non c’è giustificazione o salvezza. Dall’altro lato, l’uomo non acquista la salvezza con le opere, e la fede è un misterioso dono di Dio. E’ una tensione insanabile. Come la possiamo assumere? Personalmente credo che possiamo accoglierla solo se la collochiamo e superiamo a un livello superiore, dove essa si scioglie nel mistero della misericordia divina. Cercherò di articolare questo discorso tra poco. Finiamo per ora l’analisi dei testi.
Il v. 14b (sarà esaltato) sembra un po’ fuori posto. Stride con l’invito all’umiltà. Secondo gli esegeti, è possibile che Gesù abbia pronunciato questa frase in un’altra circostanza e che il redattore l’abbia messa qui. Come mai l’ha percepita in continuità con il testo precedente? Risponderemo alla fine. Saltiamo al brano successivo: è importante per la nostra operazione ermeneutica che dopo i brani che abbiamo letto ci sia l’episodio dei bambini. I bambini non hanno né pregiudizi, né orgoglio, né astuzie. E’ questo il modello di religiosità, preghiera e umiltà che Luca ha in mente e che forse ha in mente anche per i brani precedenti. Poi il vangelo prosegue con il racconto del giovane ricco, dove in molti si chiedono: “Chi potrà essere salvato?”. La risposta non lascia spazio a dubbi: “nessuno è buono”! Perfino Gesù si chiama fuori, con un’umiltà inaudita. Sembra dirci: gli uomini non sono in grado di fare quello che chiedo, ma la salvezza è comunque “possibile a Dio” (18, 27). Fermiamoci un attimo: quel pover uomo aveva fatto di tutto, molto più di quello che farebbe buona parte delle persone. Ma ancora non era abbastanza. Dal brano, tuttavia, non sappiamo se il giovane è stato salvato: Dio sarà stato misericordioso con lui? Gesù appare sconsolato: con una sorta di tristezza ammette che è difficile per chi ha ricchezze entrare nel regno di Dio. Cosa vuol dire “ricchezze” qui? Bel dilemma: il nostro vivere agiato non è “ricchezza”, ma rispetto a un bambino africano siamo ricchissimi. Ancora una volta qui il cristianesimo sembra diventare pauperismo, o diventa una religione per pochi eletti. Non sono cerco che possa essere né l’uno né l’altro. Ma Gesù, dopo la fermezza iniziale, ci sorprende di nuovo: “ciò che è impossibile all’uomo… è possibile a Dio”. Insomma: c’è speranza anche per i ricchi. Dio è consapevole di chiedere troppo, ed evita di dare un giudizio così netto.
Alla fine l’episodio del cieco, troviamo la fatidica sentenza: “La tua fede ti ha salvato!”. Faccio per te quel che mi chiedi, senza chiederti nulla in cambio. Qui la fede necessaria sembra essere qualcosa di estemporaneo: ancora una volta saltano i nostri criteri. Andrebbero fatte molte precisazioni: il pubblicano è giustificato (per i peccati), il cieco è salvato (dalla malattia); la salvezza, però, è anche quella eterna? Nel brano del giovane ricco la salvezza è quella del paradiso. C’è parecchia confusione!
Bene, fin qui abbiamo visto alcune stranezze dei brani. Ora cerchiamo di scioglierle, se ci riusciamo. Finora, tra l’altro, il tema della misericordia, che è una costante del testo di luca, è uscito solo parzialmente. Certo, per un teologo la dottrina della giustificazione è la dottrina della misteriosa misericordia di Dio, ma i temi sono qui terribilmente sovrapposti ad altri e vanno quindi sciolti.
Un bilancio sui brani: sembrano fatti apposta per farci impazzire! C’è una continua pronuncia di giudizi, su cui poi si ritorna per mitigarli, renderli più complessi. C’è un passaggio dall’ideale al reale, dove il secondo impone di essere meno netti e più prossimi alle difficoltà dell’uomo. Cosa può voler dire tutto ciò?
PARTE SECONDA – Alcune note personali
Se dovessi dare una considerazione preliminare – un po’ iperbolica – sarebbe questa: c’è davvero poca misericordia in questi brani! Nel primo abbiamo una persona malvagia che fa’ un’azione buona solo per non essere scocciata, e il brano si conclude con la minaccia del giudizio universale. Un Dio che promette di esaudire prontamente le preghiere, ma consapevole che non ci sarà fede sulla terra.
Nel secondo brano abbiamo un personaggio, il fariseo, che per l’intera sua vita cerca di compiere quella che gli hanno insegnato essere la volontà di Dio, ma che sbaglia a pregare, e non viene mica tanto aiutato! Per lui solo disprezzo, perfino “umiliazione”… Il pubblicano, invece, ne combina di tutti i colori (per quel che ne sappiamo: anche il pubblicano è, nel contesto neotestamentario, una figura stereotipata con funzione narrativa), e viene giustificato.
Perché il fariseo non viene giustificato? Solo perché un po’ altezzoso? Sì, non sono simpatiche le persone altezzose, peggio ancora se disprezzano gli altri. Ma non fa nemmeno particolari danni, mentre il pubblicano né fa eccome. E’ un Dio un po’ strano quello che perdona chi ruba, e non perdona chi è un po’ altezzoso… Se misericordia dev’essere, dev’essere per entrambi, o no? Ora, ammettiamolo, noi siamo un po’ tutti quel fariseo. Facciamo finta di essere il pubblicano, perché a parole ci diciamo contriti per i nostri peccati. Attenzione a una trappola sottile: quando ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo superiori per esserci riconosciuti peccatori. Ma così torniamo a essere come il fariseo!
Poi c’è un ricco che viene sonoramente umiliato, nonostante facesse un bel po’ di cose buone. E infine un cieco, che viene graziato, ma senza grandi meriti “di fede” (un’affermazione estemporanea è un po’ poco per chiamarla “fede”… Possiamo immaginare che Gesù si sia commosso per la sua vita di sofferenze, ma se il tema è la fede e la preghiera, porre questo episodio qui, non è proprio una scelta felice).
Focalizziamoci sul fariseo. Qui dobbiamo essere onesti con noi stessi: il fariseo ci sta antipatico e ci compiacciamo della punizione che riceve. Ebbene, è proprio in questo compiacimento che siamo esattamente come lui! Il fariseo, inutile dirlo, ricorda l’istituzione: quella che per tanto tempo ha disprezzato alcune categorie di persone, facendosi giudice e carnefice. Ma godere per la punizione del fariseo è farsi carnefici del carnefice e quindi rimanere nella sua mentalità, nel rancore. Il rischio che la vittima si faccia carnefice c’è sempre, purtroppo.
Il nostro modo – umanissimo – di godere della punizione del fariseo non fa che ricordarcelo. La lezione della Croce – cioè quella di una vittima che voleva essere l’Ultima Vittima, e quindi colei che rompeva per sempre la spirale del sacrificio e della vendetta, rendendo possibile il perdono – ecco, questa lezione ancora fatica a innestarsi nella nostra carne.
Allora possiamo per un attimo tornare al titolo dell’incontro di oggi. Nel brano c’è un intreccio profondo di “misericordie negate”, di misericordia non esaudita. C’è quella del fariseo nei confronti di tutti coloro lui ritiene essere inferiori, c’è quella di Dio nei confronti dello stesso fariseo. C’è la nostra misericordia negata: non quella che neghiamo a noi stessi, o che neghiamo al pubblicano. No: verso noi stessi e verso il pubblicano noi siamo ben volentieri misericordiosi. Ci risulta molto più difficile esserlo nei confronti del fariseo. Ci piace sentirci superiori al fariseo, in quanto più umili di lui. Ecco allora che la frase “chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato” mostra tutta la sua circolarità e tensione. Noi viviamo nel continuo saliscendi tra umiliazione ed esaltazione; tendiamo ad esaltarci anche quando ci umiliamo. E abbiamo quindi sempre bisogno di una misericordia che supera di gran lunga queste categorie, questo bianco\nero.
La misericordia non è una virtù naturale: certo, purché ci accordiamo sul significato di questa affermazione. Noi siamo per natura, in quanto battezzati, capaci d’amore. Almeno potenzialmente. Eppure dobbiamo imparare ad amare e a essere misericordiosi. Il brano che abbiamo letto ci mostra quanto le dinamiche di disprezzo siano dentro le nostre vene: noi odiamo il persecutore, e nel farlo diventiamo – almeno in parte – come lui.
Possiamo davvero amare i nostri nemici? Ammetto di non poter dare una risposta a questa domanda. Probabilmente no: l’amore per i nemici non è umano, è soprannaturale. E’ qualcosa che si può raggiungere solo in casi eccezionali, con l’aiuto della Grazia. Gesù c’è riuscito, sulla croce, rendendolo possibile per l’uomo. Possibile non significa ‘facile’. Inoltre, la ribellione nei confronti del persecutore è necessaria: come attuarla senza rancore, odio, violenza? Vi lascio queste domande come riflessione da fare. I cristiani Lgbt devono porsele in modo speciale: come restare nella Chiesa, criticando alcuni suoi insegnamenti, senza odiare quei membri della chiesa che pur perseguitano altri fratelli?
Stiamo al testo: entrambi i personaggi restano peccatori, uno perché non cambia la sua vita, l’altro perché resta irrimediabilmente altezzoso. Dio usa misericordia in modo inscrutabile per l’uno e non per l’altro. Singolare, quantomeno. Può bastare la contrizione di un momento se poi non si cambia la propria vita? Non è questa misericordia unilaterale, per il pubblicano e non per il fariseo, un po’ irritante? Un po’ partigiana e ingiusta?
Il brano, così come è formulato, resta difficile da digerire. Un po’ come l’indifferenza di Dio per l’offerta di Caino, o la decisione del padrone di pagare allo stesso modo gli operai che hanno lavorato di meno. O il padre che festeggia per il figlio scapestrato che è tornato e non per il figlio ubbidiente che ha lavorato per lui tutta la vita. O Gesù che guarisce il cieco senza grossi meriti acquisiti…
È vero dunque che questi versetti sono sulla preghiera, ma come preghiamo ha a che fare con quello che siamo e con quello che Dio è. Inevitabilmente, quindi, questi versetti dicono qualcosa di più. Un’ipotesi interpretativa – personale – è che queste parabole mettano a fuoco, tramite il tema della preghiera, uno dei temi più controversi del vangelo: il rapporto tra misericordia e giustizia. Proprio come in Giobbe, è qui in gioco, sottotraccia, la nostra immagine della Legge di retribuzione. Il fariseo è “reo” del peccato di disprezzare, non è solo altezzoso. E’ più grave disprezzare! Il pubblicano, invece, si riconosce peccatore e, nel far questo non giudica e non disprezza gli altri. La differenza non è nell’essere peccatori o nell’essere pentiti, ma nel modo in cui si considerano i fratelli nel peccato. Il tema della preghiera è qui solo strumentale. Il tema è quello dell’umiltà e, attraverso di esso, quello del non disprezzare gli altri. Questo appariva già nell’incipit, ma perché dunque inserire il brano nel contesto di un insegnamento sulla preghiera? Probabilmente, il modo di pregare riflette l’intimo della persona, e la sua religiosità. In che senso?
Il peccato è uno solo e sta nel farsi giudici degli altri; sta nell’attribuire a Dio i propri criteri di giudizio. Cioè credere che Dio “giustifichi” “salvi” o “castighi” come noi vorremmo che giudicasse o castigasse. Questo è quel che fa il fariseo, ma è quel che facciamo anche noi. Ci fa comodo che Dio perdoni il peccatore (il pubblicano) quando vogliamo scusare le nostre mancanze; non ci va bene che perdoni il fariseo. Non sopportiamo che una persona ingiusta (il giudice) possa essere strumento di giustizia. Spesso preghiamo e preghiamo, ma le grazie non arrivano: mentre al cieco viene accordata subito. E ci arrabbiamo anche con l’atteggiamento di Dio verso il cieco.
Forse la fede che Gesù ‘non troverà’ è esattamente questa: abbiamo fede in un Dio che ha ‘i suoi’ e non ‘i nostri’ criteri per giudicare e salvare le persone? Abbiamo fede nella complessità della realtà, che ci impone di smetterla di mettere tutti (anche Dio!) nelle nostre categorie di ragionamento? Riusciamo a essere un po’ meno razionalisti e un po’ più misericordiosi? Un po’ più umili nella nostra pretesa di comprendere e comprimere tutto nei nostri schemi? L’umiltà che qui è richiesta è quella nei confronti di Dio: Egli sovrasta la nostra facile giustizia, la nostra legge della retribuzione, il credere che, per il fatto che uno prega, sarà esaudito. C’è di più, c’è ben altro. Ma non vale neanche la regola opposta! Non valgono regole! Le parabole sembrano spingerci verso una dimensione diversa: pregate e fate il bene senza misura, perché non avete e non avrete alcuna certezza di quale sia la misura giusta! Anche quando sarete convinti di aver fatto abbastanza, o di aver fatto troppo, Dio vi sorprenderà ribaltando il vostro punto di vista. Fate il bene e pregate per il bene e per stare in compagnia di Dio, non per dei calcoli che credete di poter fare. Sbaglierete comunque i calcoli, perché non avrete mai accesso a tutti i sentieri dei cuori, degli altri e i vostri. Siate umili!
Ecco allora che tutte le tensioni del brano possono trovare almeno un senso parzialmente unitario: questi brani hanno lo scopo preciso di metterci in confusione, di rompere i nostri schemi, di mostrare una misericordia che ogni volta agisce in modo imprevedibile. Non perché sia casuale, ma perché è operata secondo una logica che sovrasta infinitamente la nostra conoscenza[3]: è la conoscenza e la giustizia di Dio, nella quale misericordia e giustizia coincidono in un modo che a noi non è accessibile. Capiamo allora i bambini: la loro religiosità è quella che non disprezza, è quella di giocare con gli altri bambini con spontaneità. E’ la religiosità che non pretende di capire certi misteri, o di restringerli alle proprie categorie. E’ il modello di bontà senza calcoli. Capiamo anche il giovane ricco e il cieco: capiamo perché Gesù agisce in quel modo, in parte smentendosi. Lo fa perché si rende conto che nessuno ha il diritto di dire quando uno ha fatto abbastanza per salvarsi, o quando uno ha una fede sufficiente. Questo giudizio spetta a Dio soltanto. Evitiamo di darcelo tra di noi. Questa lettura autorizza a interpretare quel “pregare sempre” nel senso di fare della propria vita una preghiera, cioè una lode a Dio: senza preoccuparsi delle prestazioni. Facciamo del nostro meglio, il resto lo aggiungerà Dio.
Se questa lettura è plausibile, anche quel “prontamente” può avere un suo senso. Il ‘prontamente’ si applica a tutte le volte in cui la preghiera è compiuta nel modo corretto, con purezza di cuore e per fini buoni, congruenti con il piano di Dio. Eppure, se il nostro ragionamento è corretto, non sapremo mai quando la nostra preghiera corrisponde a questi canoni.
Ed è Dio stesso, potremmo dire, a volerci lasciare nel dubbio: non crediate di aver fatto le cose per bene, perché non saprete mai quando lo avete fatto davvero. Evitate quindi di leggere ciò che vi succede come premi o castighi… Non sostituitevi a Dio, siate umili! Dio esaudisce prontamente le vostre preghiere, ma non sapete né quando né come: evitate di esaltarvi credendovi graziati o fortunati, o credendo di aver ottenuto da Dio – sottomettendolo – ciò che volete. Siate umili! Questo è l’unico modo per essere misericordiosi.
* Damiano Migliorini è filosofo, specializzato in scienze religiose, autore, con B. Brogliato di L’amore omosessuale. Saggi di psicoanalisi, teologia e pastorale. In dialogo per una nuova sintesi, Cittadella 2014.
_______________
[1] Per chi fosse interessato a una rapida sintesi: S. A. Davison, “Petitionary Prayer”, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2016), E. N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/petitionary-prayer/>.
[2] Il testo greco usa il verbo in modo diverso per esprimere i due modi di stare in piedi – mi è stato fatto notare durante l’incontro – e questo potrebbe avere un significato. E’ una questione da approfondire!
[3] L’approccio che ho proposto non equivale a sospendere le norme morali. Gesù, tutto sommato, dei giudizi li dà: questo significa che una morale oggettiva è possibile, che possiamo – come Chiesa – indicare quale siano i peccati gravi, senza però aver la pretesa di escludere qualcuno (per esempio dall’Eucaristia) perché ‘crediamo’ egli si trovi in peccato mortale. Quest’ultima è una condizione che solo Dio può definire. Tra di noi dobbiamo evitare di attaccarci etichette di questo tipo, riconoscendoci tutti in cammino verso una verità che, pur essendoci, ci sfugge sempre nella sua totalità. In quanto uomini contingenti e limitati, le norme morali codificate socialmente sono indispensabili, così come è indispensabile il giudizio e la punizione (entrambi per approssimazione) che la società infligge ai membri che non le rispettano. Ma questo è un altro piano: il Vangelo ci parla del giudizio che noi diamo rispetto alla dignità dell’altra persona e del suo rapporto con Dio, quindi sulla sua salvezza. Su questo, non ci è permesso essere giudici. Solo Dio è in grado di conoscere tutte le motivazioni e le circostanze, e quindi di dare un giudizio definitivo – oggettivo, ma per noi sempre infinitamente incomprensibile.